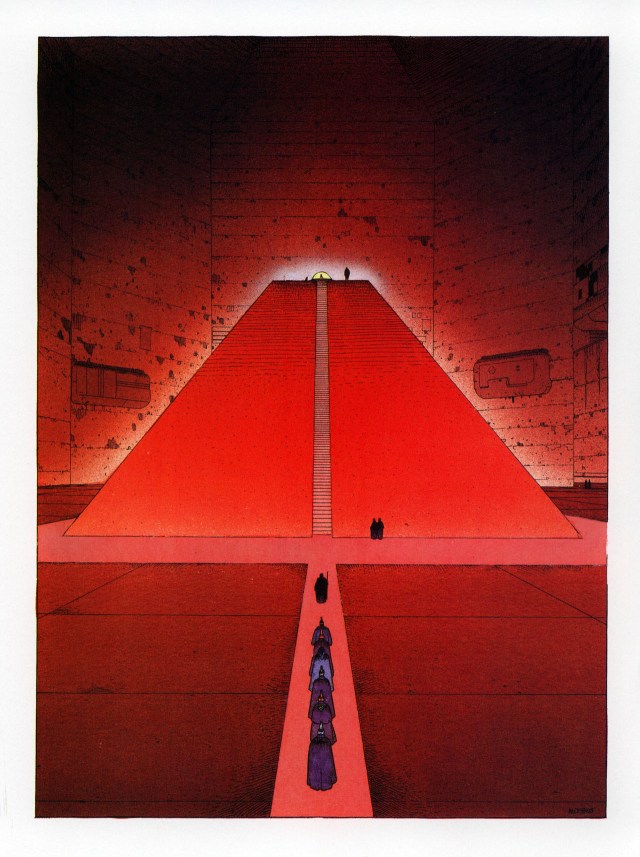| A parziale compendio ovvero a corollario di quanto apparso ieri con lo stesso titolo copio qui un bel fondo apparso oggi, sì domenica, in Pangea, la rivista corsara di letteratura in quanto navigazione corsara; l’autore è quasi di sicuro il nume della rivista Bullo, che non si firma ed è già un indizio. Habeat corpus.
Vacanze, ovvero: epica della diserzione
Panottico. L’altra faccia di Pangea
Vacanza porta in seno le stigmate del vuoto. Vacante, per via etimologica, significa “esser vacuo”, cioè “rimanere vuoto”. Vacuità, vuoto: concetti eccelsi se si è un contemplativo – ci si svuota di sé, per empire il vuoto, per fare ingresso nell’empireo del vuoto. Nel contesto odierno, piuttosto, la vacanza è l’emblema del vuoto pneumatico del ‘vacanziere’, figura sempre felice e sempre frustrata che vagabondeggia da una brandina all’altra, veleggia tra una scarrozzata a cavallo, una tornata in bici, una missione montana: il tutto ad alta densità ‘sociale’ (o social, è uguale), pagandosi il confort di essere lì come altrove, mera cartolina turistica; pagandosi, per lo più, il privilegio della frustrazione.
Alla parola vacanza, preferiamo allora diserzione, che significa abbandonare una bandiera – quella estiva, festivaliera – che non si ritiene più propria, e, in profondità, fare di sé un deserto, desertificarsi, devastarsi. Come vedete, tra il vuoto dell’autentica vacanza e il deserto della diserzione c’è un’affinità paradigmatica, paradisiaca, spirituale. In fondo, qui, si tratta di riassegnare il giusto posto ai segni, deviati dalla bulimia d’uso dell’oggi.
Per il resto, il nostro addestramento passa per Melville. Piaceva tanto a Carl Schmitt.
La vita per mare di Herman Melville dura quattro anni, dopo aver tentato vari lavori, compreso l’insegnante. Il primo lungo viaggio, imbarcato come marinaio, lo fa nel 1839, sul “St. Lawrence”: ha vent’anni e percorre la tratta New York-Liverpool. Molti anni dopo, nel 1855, esaurita l’ennesima vita, quella da letterato, ritenuta insoddisfacente, Melville è di nuovo a Liverpool, fa visita all’amico Nathaniel Hawthorne, a cui ha dedicato Moby Dick, autentico, evanescente, leggiadro leviatano della letteratura americana, lì in qualità di console, grazie ai benefici ottenuti dall’intimità con Franklin Pierce, quattordicesimo Presidente degli Stati Uniti d’America. “Melville, come sempre, cominciò a ragionare della Provvidenza e della vita futura, e di tutto ciò che è oltre la conoscenza umana, e mi informò che ‘era più o meno giusto alla conclusione che sarebbe tornato al nulla’, e però non sembra trovar riposo nella previsione” ricorda, Nat.
*
Il primo vero impiego, però, Melville lo ottiene nel dicembre del 1840 quando si imbarca sull’“Acushnet”, una baleniera che fa rotta verso il Pacifico. Il 23 giugno del 1842 l’“Acushnet” attracca a Nuku Hiva, nelle Marchesi. Il porto naturale è placido, ma nessuno osa sfidare i boschi, notoriamente abitati da popolazioni cannibali. Il 9 luglio, insieme a Toby Greene, Melville diserta “e si nasconde nei recessi dell’isola”. Un mese dopo, i due si impiegano su una baleniera australiana, la “Lucy Ann”; Melville si allea agli ammutinati. Processato, arrestato a Tahiti, Melville scappa con un altro compagno, John B. Troy, nell’isola Eimeo, dove si arrangia come coltivatore di patate. In seguito, riesce a imbarcarsi sul “Charles & Henry”, che gli consente di arrivare alle Hawaii, nell’aprile del 1843. Lì ottiene l’ultimo impiego della sua vita da marinaio, sulla “United States”, percorrendo il Pacifico, fino all’ottobre del 1844.
*
Come si sa, gli anni di vagabondaggio nel Pacifico sono lo sfondo dei primi romanzi di Melville, Typee (1846), Omoo (1847) e Mardi (1849). Il Pacifico è il liquido amniotico del Melville romanziere: “Da tempo pensavo che la Polinesia offrisse una notevole quantità di ricco materiale poetico che non è mai stato finora sfruttato in opere di fantasia”, scrive, nel 1848, al suo editore, John Murray. Al Pacifico è dedicato uno dei capitoli più poetici di Moby Dick: “C’è non si sa quale soave mistero in questo mare, le cui movenze delicatamente tremende paiono dir d’una qualche anima che là sotto si celi… Ed è appropriato che sopra questi pascoli marini, sopra il vasto rollio di quest’acquee praterie, sopra questi campi del vasaio dei quattro continenti, le onde s’alzino e s’abbassino e fluiscano e rifluiscano incessantemente, poiché qui milioni d’ombre e di parvenze si mescolano, sogni annegati, sonnambulismi, fantasticherie e tutto ciò che chiamiamo vite e anime qui giacciono sognando, sognando, sempre…” (cito dalla traduzione di Alessandro Ceni, il poeta, realizzata per Feltrinelli, 2007).
*
Dieci anni dopo la pubblicazione di Moby Dick, Melville è ancora lì, nel Pacifico, a cercare, forse, la giovinezza perduta, l’estro della scrittura sorto, per diserzione, alle Marchesi. Ne scrive al primogenito, Malcolm, che morirà in modo atroce, diciottenne, sparandosi, a New York. “L’altro giorno abbiamo avvistato una baleniera; ho preso una scialuppa e ho navigato nell’oceano fino alla baleniera, sono stato lì per un’ora. A bordo c’erano otto o dieci “selvaggi”. Il capitano della baleniera li ha arruolati in una delle isole intorno a Rarotonga. Dovrebbero aiutare a tirare la balena dopo che è stata catturata”.
*
A Nuku Hiva, nel folto, in quella cattedrale di foreste, Melville rimane per un mese. Che cosa succede? È il sommo segreto melvilliano. Alcuni suppongono che Melville sia stato iniziato ai riti tribali, penetrando negli oscuri enigmi delle leggende isolane. Ad ogni modo, così ne scrive Elémire Zolla: “Due marinai americani scappati dalle loro navi si sono rifugiati presso una tribù delle Marquesas. Stranamente le statue degli dèi maggiori sono adagiate nel verde fittissimo e umido e nessuno fa mai cenno a queste presenze. La vita si svolge tenera, sensuale, trasognata, scherzosa. Ma forse è un inganno, la verità è in quegli angoli segregati, in quelle oscurità stillanti”. Alle Marchesi Melville ammira la – apparente – marcescenza del dio, il dio-feticcio divorato dalla selva, simulacro che si consuma perché deve consumarsi. Così un passo di Typee tradotto da Luca Orlandini in Nuku Hiva (Magog, 2022): “Il simulacro, in sé, era solo un pezzo di legno grottescamente scolpito… Era in un pessimo stato di conservazione. La parte inferiore era ricoperta da una lucente patina di muschio. Sottili steli d’erba spuntavano dalla bocca spalancata e contornavano il capo e le braccia. Le sue caratteristiche divine erano letteralmente giunte a quella decadenza che detta la selva, quando prende il sopravvento. Tutte le sue parti in rilievo erano ammaccate e logore, o del tutto marcite. Il naso era addirittura scomparso, e dalle condizioni generali della testa, veniva da supporre che questa lignea divinità, esasperata dall’incuranza dei propri fedeli, avesse tentato di spaccarsi il capo contro gli alberi circostanti”. L’incuranza come atto di fede – il feticcio esiste perché si consumi, con scostumata indifferenza – scoscendere nel nulla.
*
Francesco Saba Sardi ha curato un’edizione di Taipi per Mondadori (1984), e ne scrive in questo modo: “Se Melville è autore, più che del suo, del nostro secolo (e anzi di questo dopoguerra di illusioni cadute), è per merito di una coscienza incerta quanto impietosa. Nessuna amplificazione leggendaria di un’autobiografia: Taipi non è affatto questo, bensì il disincanto, e pertanto il rifiuto di ogni autobiografismo… L’atmosfera di queste pagine non è certo gioiosa: la selva è feroce, l’isola implacabile, gli indigeni perfidi… il mito personale di Melville è catabatico”. Discesa agli inferi, catabasi. Melville è attratto dal mondo magmatico, magnetizzato di spiriti, degli isolani – e ne è rifiutato, rigettato. Orfeo perde cetra, lingua e certezza: nulla può risorgere, lo scrittore porta lo stigma del lebbroso, il marchio del profeta.
*
Mentre nell’estate del 1842 Melville diserta e si inoltra tra i recessi di un’isola sperduta nel Pacifico, Nathaniel Hawthorne – così leggiamo nei suoi diari – fa il bagno nel fiume vicino a Concord, Massachusetts – “la sua acqua è di piacevole effetto immediato, essendo soffice come il latte” –, che sfida anche di notte, al “chiaro di luna” – “era calmo come la morte, m’è parso di tuffarmi nel cielo” –, e pranza con Henry David Thoreau, “una persona singolare… brutto come il peccato, col naso lungo, la bocca strana e con modi rozzi e rustici, sebbene cortesi”. L’amicizia tra Melville e Hawthorne, sodalizio tra i più alti della letteratura, comincia nel 1850. “È uno sguardo strano, pigro, ma con una forza abbastanza unica. Non sembra attraversarti, ma prenderti dentro di sé”. Con queste parola Sophia Hawthorne, adorata moglie di ‘Nat’, descrive gli occhi di Melville, lo sguardo onnivoro. Ne è conquistata.
*
La catabasi a Nuku Hiva, l’avventura tropicale tra i cannibali, segna Melville per sempre. Secondo i ricordi della nipote, Eleanor Melville Metcalf, “Nell’angolo c’era una grande poltrona, dove lui si sedeva sempre quando lasciava i recessi del suo oscuro mondo privato. Gli salivo sulle ginocchia, mentre mi raccontava storie fantastiche di cannibali e isole tropicali”.
*
La diserzione è il carisma di Melville. Melville diserta per avviarsi nel suo deserto: abbandona il mondo degli uomini, la consuetudine letteraria, le convenzioni editoriali. Nel 1885 a James Billson scrive: “Quanto alla fama irraggiunta – cosa importa? La nostra civiltà avanza in un presente in cui diventano famose, ancor più in campo letterario, le cose che hanno successo commerciale. Questa specie di fama, prodotta su ordinazione, fabbricata dalle agenzie, è vanità delle vanità, lo sappiamo bene”. C’è un’analogia tra il pellegrinaggio negli oceani, quello a Gerusalemme – stralunato, involuto, mesmerico – messo in versi in Clarel, e la fuga tra le foreste di Nuku Hiva. Il primo gesto di vita di Melville, quello che ne ha forgiato la giovinezza e foraggiato il futuro, è un gesto di diserzione; non di rinuncia, di viltà, da disadatto, bensì il tuffo verso l’ignoto. Meglio la foresta fitta di dèi ottenebrati dal muschio e di cannibali all’ignavia della barca, al reggimento, ai comandi sfiduciati.
*
L’ultima, estrema diserzione è da se stessi, dalla propria opera. Quando il pittore Peter Toft gli chiede ragione dei suoi libri, Melville lo blocca: “Sembrava fare poco conto delle sue opere, e scoraggiò i miei tentativi di discuterne. ‘Le conoscete’, diceva, ‘ meglio di me. Io le ho dimenticate’”. In effetti, riuscì a farsi dimenticare. Nel necrologio pubblicato dal “New York Times” il 29 settembre del 1891 Melville è ricordato come scrittore di “racconti di mare”, come “l’autore di Typee”. Tre giorni dopo il quotidiano ritorna sulla notizia, per trarne una nota moraleggiante: “L’eclissi totale di quello che pareva un luminare della letteratura pare un capriccio sfrenato della fama, in ogni caso, è un monito amaro e salutare per i romanzieri di oggi… I mari del Sud del Pacifico erano il suo territorio di scrittura”.
In fondo, è annegato e risorto, Melville; fu quasi un battesimo. Il patriarca sul dorso della Balena Bianca.
Ci sarebbe da urlare al miracolo editoriale. Ovviamente, dobbiamo fare copia-incolla guardano oltre la tendina delle Alpi. Riassunto bibliografico. Nel 1987 – poi 2004 – Il Mulino edita Il nodo di Gordio: dialogo su Oriente e Occidente nella storia del mondo tra due titani del pensare, Carl Schmitt e Ernst Jünger (ora ripreso da Adelphi). Nel 1999 – poi 2012 – l’editore tedesco Klett-Cotta pubblica il carteggio tra i due, che testimonia una amicizia durata dal 1930 al 1983, pochi anni prima della morte di Schmitt (1985). Nel 2020, in Francia, Editions Krisis traduce quella Correspondance (1930-1983) con didascalia esemplare: “Ernst Jünger, il più noto tra i grandi scrittori tedeschi contemporanei, e Carl Schmitt, il politologo più citato e commentato al mondo, si sono incontrati la prima volta nel 1930. Da allora, hanno coltivato un rapporto di amicizia basato sulla reciproca stima. Entrambi hanno assistito in prima persona agli sconvolgimenti del XX secolo. Durante il Terzo Reich, Jünger optò per un esilio interiore, mentre Schmitt preferì compromettersi con il nazionalsocialismo. La loro amicizia fu profonda, e la loro elevata posizione intellettuale continua a illuminarci”. Da quel carteggio, in particolare, abbiamo estratto le parti che rivelano l’interesse di entrambi verso l’opera di Melville e di Edgar Allan Poe. In uno studio del 2006, Carl Schmitt’s Myth of Benito Cerano, pubblicato su “A Journal of Germanic Studies”, Thomas O. Beebee scrive: “Carl Schmitt, specialista di diritto pubblico e costituzionale, resta la figura più controversa della cultura giuridica tedesca, uno dei pochi intellettuali di destra che continui ad attirare studi e interesse; è il pensatore politico più legato alla letteratura del XX secolo, colui che ha permesso al mito e alla finzione di irrompere nel diritto per creare una ‘teologia politica’… Insieme all’amico Ernst Jünger ha letto i grandi autori americani, Herman Melville e Edgar Allan Poe su tutti, come profeti della situazione globale della Seconda guerra e del dopoguerra, compreso il tramonto dell’epoca delle sovranità nazionali. In particolare, Schmitt cita il Benito Cerano di Melville nella sua opera più di qualsiasi altro testo della letteratura mondiale pur non dedicando a quel libro un saggio specifico”. In Ex Captivitate Salus Schmitt paragona la propria situazione a quella di Benito Cerano. Lo scambio di lettere tra Schmitt e Jünger ne esplicita le passioni letterarie: Schmitt è un assoluto melvilliano; Jünger ha maggior sintonia con Poe, forse per il suo talento nell’esplorare ambiti letterari diversi, difformi, coniugando la propria poetica allo studio scientifico, tra l’occulto e l’oggettivo, l’esperienza dell’enigma.
***
Carl Schmitt a Ernst Jünger, 25 febbraio 1941
Caro Jünger, sono stato molto felice di ascoltarla. Sua moglie mi ha scritto qualche giorno fa: attendo marzo per incontrarla. Le invio il Benito Cerano di Melville. Purtroppo, non riesco a trovare Moby Dick. Spero di acquistare presto Billy Budd. Sono sopraffatto dall’involontario simbolismo di questa situazione…
*
Ernst Jünger a Carl Schmitt, 3 marzo 1941
Caro Staatsrat! Ho ordinato tutti i libri di Melville e te li donerò se me ne invierai altri. Ho sentito dal mio fornitore di libri che Moby Dick è attualmente introvabile. Ho letto Billy Budd anni fa. Egli è un chiamato, un uomo braccato da chi – un malvagio superiore che lo tratta da subordinato – vuole distruggerlo…
*
Carl Schmitt a Ernst Jünger, 4 luglio 1941
Sarei estremamente felice di incontrati al Ritz, a Parigi, caro Jünger, e bere una bottiglia di vino con te. Il desiderio di tali piaceri levita: il vino e gli amici diventano cose rare. Ho letto il libro di Giono su Melville. L’inizio è bellissimo: si resta deliziati dall’arte paesaggistica francese, che fa vedere tutto, subito. Poi si toccano i temi centrali e il libro risulta effeminato, altero, anodino. Questa miscela di anarchismo e di sensualità mi disgusta. Melville è ridotto a un autore kitsch, anche se la sua impareggiabile grandezza sta nel creare una situazione oggettiva, elementare, concreta. Benito Cerano è più grande dei russi e degli altri scrittori dell’Ottocento; anche Poe si ritrae, al suo cospetto. Moby Dick, poi, come epopea dei mari, può essere paragonato soltanto all’Odissea. Soltanto Melville, intendo, è in grado di rendere palpabile, presente il mare come elemento. Un argomento decisivo per i nostri tempi…
*
Ernst Jünger a Carl Schmitt, 28 agosto 1941
…Sto ancora leggendo Moby Dick. Il romanzo ha un carisma effettivamente cosmico. Ricordo spesso la frase, “e Leviatano suona”, credo sia di Klopstock. Capisco l’interesse del mondo economico per questo maestoso animale: egli è il distruttore. Il misero demoniaco gioca un ruolo nella vita, diventa visibile tra i fuochi fiochi delle caldaie nutrite a olio di spermaceti. Non posso essere d’accordo sul giudizio che dai di Poe rispetto a Melville. Poe è e resta il grande maestro, che dipinge i contorni e la matematica di mondi pericolosi. Si irradia in molteplici direzioni – tocca questa, ad esempio, in Maelström, Gordon Pym e nella sua cosmografia.
*
Carl Schmitt a Ernst Jünger, 17 settembre 1941
…Se riusciamo a incontrarci vorrei spiegarvi il mio punto di vista su Melville. Non volevo sminuire Poe. Penso che Benito Cerano sia il simbolo di una situazione, ed è argomento inesauribile. Moby Dick è disponibile in francese?
*
Ernst Jünger a Carl Schmitt, 8 aprile 1943
Caro Schmitt, le tue lettere del 16 e del 21 marzo mi sono giunte. Voglio ringraziare te e la tua cara moglie per i cordiali auguri di compleanno. La giornata è iniziata simbolicamente: lo Stato, spostando l’orologio in avanti, ha rubato un’ora alla mia vita. In seguito, ho fatto un sogno importante su Eva e la sua progenie. Si adattava all’animo del giorno e si è trasformato nella prima nota che ho scritto all’inizio del nuovo anno della mia vita. Il primo a farmi gli auguri è stato il generale Hans Speidel: mi ha telefonato da Poltava. Mi affascina la connessione di immagini tra Poe e Melville, nel tuo sogno – mentre Poe osserva come individuo, Melville ha uno sguardo politico e sociale. Unendoli, raggiungiamo il carattere di un uomo contro la cabala dei cospiratori.
|